PUBBLICAZIONI
Qualsiasi cosa che sia sradicata dalla Vita e dalle domande che l’esistenza pone,
perde ogni potere di insegnare qualcosa a qualcuno.
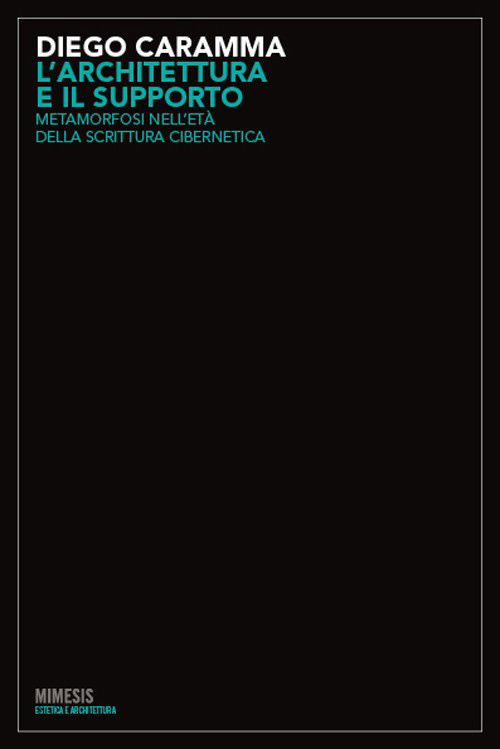
Diego Caramma
2010
Estetica e architettura
Mimesis Edizioni
La «rivoluzione informatica» di cui da tempo si parla riguarda, più che «rivoluzioni», «soglie», varcando le quali, in modo più o meno profondo, avvengono altrettante metamorfosi: l’emergere di un nuovo «supporto» che apre verso una rievocazione di un’unità di senso secondo la quale l’architettura dovrà necessariamente ridefinirsi nell’ambito di una nuova sensibilità e consapevolezza contestuale; l’emergere di un’«anima cibernetica» capace di configurare un’estensione della «dimensione psichica» e rendere esplicita la nozione di mente come textum, rifuggendo dalla violenza di punti di vista assoluti e astratti rispetto alla disposizione all’apertura dell’evento dell’umano e alle costitutive relazioni che lo caratterizzano; l’emergere di una nuova figura di laico e del suo corpo «plurale e multiverso». Soglie nient’affatto distinte, ma vicendevolmente intrecciate e tematizzate nell’ambito di un percorso di ricerca inedito, aperto a occasioni future.
“In breve, solo l’effetto che lo scritto eserciterà sui lettori
ai quali è destinato è un argomento decisivo per
stabilire se si è raggiunto o no il proprio intento, e
l’autore non ha qui alcuna voce in capitolo”.
J.G. Fichte
Ammesso che questo lavoro abbia un merito, esso riguarda unicamente il fatto di aver tentato di intrecciare pensieri e ricerche, appartenenti a campi a volte anche differenti, allo scopo di realizzare un incontro che potesse essere, per i problemi e i temi che attualmente ci riguardano, quanto meno fruttuoso.
La scelta di riproporre pure con lunghe citazioni le parole d’altri deriva da una volontà ben nota e non dissimile da quella di Walter Benjamin. Benché mai citato, egli è presente esattamente in questo senso, intrecciando e interrogando testimonianze e segni eterogenei e talvolta sconcertanti nell’intento di conferire loro un senso ulteriore.
Ciò che tuttavia qui si propone non è una «teoria», ma un esercizio, una prospettiva interpretativa caratterizzata da contraddizioni e inevitabili errori, che sono però anche espressioni di una volontà di comprensione che non nasce a freddo, sul tavolo di lavoro del critico o dello storico, ma trae origine da azioni e progetti concretamente vissuti e in parte passionalmente realizzati fra illusioni, sogni e delusioni, con tutto ciò che questo comporta in termini di rischi, insuccessi e sconfitte, cui si accompagnano occasioni di rinascita e speranza.

Diego Caramma
2009
Saggi Contemporanei
Seneca Edizioni
“Bisognerebbe avere il coraggio di rileggere e fare proprie le istanze e le battaglie civili di un grande personaggio come Danilo Dolci. Colui la cui esistenza e la cui opera, secondo Erich Fromm, alimentano la speranza nella sopravvivenza dell’uomo. Ma quelli erano gli anni dei Norberto Bobbio, dei Lucio Lombardo Radice, dei Carlo Levi, degli Elio Vittorini, degli Italo Calvino, dei Piero Calamandrei, dei Galante Garrone, dei Parri, dei Pertini, dei Capitini, degli Zevi”.
Ecco uno dei brani che segnano le stazioni di un percorso che si sviluppa attraverso saggi e brevi appunti raccolti e rifusi al fine di tessere un itinerario di pensiero che si dipana tra tematiche fra di loro apparentemente eterogenee eppure strettamente intrecciate: dalla questione del segno (problema che sta al cuore dell’Occidente) fino ai paesaggi informi e incontrollabili di molte aree suburbane e abusive il cui mobile confine è spesso, e sempre di più, definito dall’onda mobile dei compagni di viaggio di quei cadaveri la cui vita si schianta sugli scogli dei nostri mari – vite senza nome che approdano alle rive di un mondo occidentale in perenne divenire, che ogni giorno (ma come detriti reietti di una società opulenta che vive alle spalle dell’«altro»), contribuiscono a costruire.
La critica e la storiografia dell’arte e dell’architettura devono necessariamente fare i conti con un’urgenza di carattere, per così dire, metodologico, che implica anche una presa di coscienza: le descrizioni e le narrazioni prodotte non dicono affatto come le cose, o «i fatti», si siano effettivamente svolti, ma sono il segno di quelle soglie che, a partire dallo sguardo contemporaneo, e cioè dalle pratiche di vita e di sapere che ci costituiscono, direbbe Sini, riconosciamo come decisive per l’apparizione di ciò di cui parliamo. Tematizzare la genesi in senso genealogico non ha perciò nulla a che vedere con la sua tematizzazione in senso storico-empirico. L’operazione genealogica non può evitare di chiarire il senso della propria provvisoria ricostruzione, interrogandosi su se stessa. La retrospezione che in questo modo si realizza ha di mira l’originaria apertura di quella conseguente emergenza che noi siamo. Ma allora ciò significa che abitando la nostra soglia «osservativa», i rapporti tra origine e destinazione si fanno più complessi di quel che a prima vista appare: l’origine si mostra in qualche modo come un «prima» (che cerchiamo, ma sempre ricerchiamo) e, nel contempo, come un «dopo» che emerge al di qua della parola di cui ci serviamo, ovvero al di qua di un transito già avvenuto. Non si raggiungono realtà «in sé», proprio perché l’origine non è un che di definito (infatti l’origine è un evento, che accade sempre di nuovo e che va continuamente ricercato e ospitato nella propria pratica di vita e di scrittura). Si raggiunge, semmai, una rivelazione interna alla nostra prassi linguistica, al nostro sapere (che a sua volta sconta un debito non indifferente con una «sapienza corporea» ben più antica, benché inavvertita). Tutto ciò non riduce affatto l’importanza della ricerca e i suoi risultati, ma mostra l’esercizio intrinseco di ogni riflessione e il carattere di ogni scoperta quali emergenze interne ad una (la nostra) esperienza. Queste sono le ragioni per battersi ancora più decisamente contro uno storicismo di maniera e difendere con qualche argomento in più la necessità della «critica operativa» tanto cara a Bruno Zevi, ma evidenziandone un senso ulteriore.
Va aggiunto che, per il critico, tanto le opere d’architettura, quanto i protagonisti delle sue analisi, non possono essere altro che «figure» messe in opera nell’ambito del proprio percorso. «Figure in transito», come ci è stato insegnato, e che, come tali, non vanno assunte ideologicamente dalla parte del loro «significato», cioè come oggetti indipendenti dalle pratiche che li mettono in opera. Si potrebbe dire che essi sono piuttosto espedienti per fare questione di un determinato processo di formazione e, quindi, di quelle emergenze che noi siamo: la critica lascia tracce, incide, in qualche modo, ciò di cui parla, e lo fa perché non si risolve in un punto di vista contemplativo, ma incarna le movenze di un gesto che trasforma ciò che vorrebbe limitarsi a contemplare. In ciò, ritracciando e riconfigurando sempre di nuovo la propria origine e il proprio destino, condizione di ogni esperienza.
Parlare d’architettura ci pone sempre dalla parte del significato. Ma l’architettura, se intesa nel suo senso profondo, per vivere come architettura va intesa come prassi: o dell’architettura è dato fare esperienza, o l’architettura, letteralmente, muore, perché ridotta a simulacro. Con ciò si capisce come l’organizzazione spaziale, con le sue costitutive relazioni, ne divenga la cifra caratterizzante.
Del resto, i fondamenti vanno sempre rivisitati. Sicché, anche di fronte alla verità, è importante operare la distinzione tra le sue due facce: essa, infatti, non è qualcosa di monolitico. La verificazione della verità, come direbbe forse ancora Sini, è ciò che non è in possesso della sua fondazione. Il potere, però, esige esattamente questo, vorrebbe cioè trattenere la verità per garantirne il significato assoluto e intramontabile, cioè nato morto. Ma non può farlo, perché il significato non appartiene a nessuno, vive transitando, sta ovunque produce effetti, diceva Peirce. Ma ciò, ecco il punto, non dipende dalla nostra volontà. Del resto, il significato della nostra vita non appartiene a noi, ma agli altri. Solo gli altri potranno dire ciò che è stata una vita, e potranno farlo solo fino a quando essa produrrà effetti. Forse, tutto ciò ha qualcosa a che vedere con quella profonda fede mazziniana secondo cui la propria vita sarebbe fatta per essere proseguita in quella degli altri.
Anche per questo è così essenziale che la scrittura, l’architettura, l’arte, siano libere, e non asservite. Del resto, noi non siamo in grado di predeterminare le condizioni di colui che leggerà e che vivrà gli edifici che progettiamo. Non siamo in grado ed è auspicabile che non sia così, se davvero abbiamo capito ciò che si sta dicendo. Chi scrive, in fin dei conti, non cerca la condivisione della verità istituzionalizzata (il consenso di milioni pronti ad acquistare l’ultima scemenza editoriale), ma si apre al riconoscimento che non sa ciò che accadrà del suo scritto e nel suo scritto. Non può predeterminarne le circostanze, perché la continuità evolutiva è condizione della vitalità di ogni verità.

Diego Caramma
2008
Saggi Contemporanei
Seneca Edizioni
Ripercorrendo le vicende del passato nel modo in cui ci è dato ripercorrerle ci esponiamo a quell’esercizio genealogico che ci consente, in prima istanza, di guardarci criticamente nel tentativo di comprendere quali soggetti siamo vieppiù diventati e il modo in cui lo siamo diventati attraverso l’intreccio di innumerevoli pratiche in sinergia e perenne trasformazione. Nel modo di pensare il nostro rapporto con l’«altro» tutto ciò ha evidentemente un ruolo essenziale. Come pure nel comprendere il modo in cui è mutato l’approccio dell’uomo nei confronti dello «spazio», del «tempo», della «luce», della «materia», che non sono nient’altro che metafore che da un certo momento in avanti l’uomo impiega ma che non esistono come tali, come cose «assolute» (absolute, cioè sciolte dalle pratiche che le mettono in opera), né esistono come cose esistenti «in sé» al modo in cui le parole le dicono e le designano. Che la maggior parte degli architetti, oggi, non sia in grado di esporsi al rapporto con l’«altro», di pensare criticamente i fondamenti della propria pratica, va di pari passo con il venir meno del senso dell’architettura, che si è via via disseccato nel significato di una «vita calcinata», come diceva Antonin Artaud.
Questo non significa né assumere atteggiamenti nostalgici né rifugiarsi nella tradizione di saperi esotici od orientali, mettendo in atto quelle categorie aristoteliche che intendiamo superare. Ma dall’altro lato ciò non deve indurre ad elogi indiscriminati e superstiziosi di quel sapere scientifico e tecnologico che la modernità ha imposto e andrà vieppiù imponendo alle altre culture e tradizioni (sempre più sul punto di scomparire dalla faccia della terra). Il punto allora è cercare di esporci ad un abito etico (che non ha nulla a che fare con la teorizzazione di scale di valori) verso il quale alcuni filosofi ci stanno da tempo richiamando nel tentativo quanto mai urgente e necessario di «tornare a casa» e ricostruire l’arte «rituale» della nostra formazione.
Noi «veniamo dopo», come ormai sappiamo e non possiamo far finta di non sapere. Ciò non vuol dire che nelle vicende umane non siano rintracciabili vie alternative e slanci creativi capaci di aprirsi ad un senso solidale dell’umano che il nostro tempo in molti modi suggerisce e sollecita.
“Davvero non c’è nessuno che non teniamo in gran conto tra coloro che si sono appoggiati al proprio ingegno per contemplare le cose e che hanno costruito qualcosa con arte e metodo”.
Giordano Bruno, Hermes, in Le ombre delle idee (De umbris idearum,1582)“L’esperienza è la nostra sola maestra. (…) È con la sorpresa che l’esperienza c’insegna tutto ciò che si degna d’insegnarci”.
Charles S. Peirce, Conferenze sul pragmatismo (1903)“L’immediato perseguita il recensore. Ma, ovviamente, il critico ha delle responsabilità particolari verso l’arte della propria epoca. Deve chiedere ad essa non soltanto se rappresenta un progresso o un affinamento tecnico, se imprime una direzione nuova allo stile o se gioca abilmente sulla sensibilità del momento, ma che cosa porta o che cosa sottrae alle riserve impoverite dell’intelligenza morale. Qual è la misura dell’uomo che quest’opera propone? Non è un problema che si possa formulare facilmente o che possa esser posto con tatto infallibile. Ma i nostri non sono tempi normali. Soffrono sotto la tensione dell’inumanità, sperimentata su una scala di singolare grandezza e orrore; e le possibilità di rovina non sono molto lontane. Il distacco, a volte, è un lusso che uno vorrebbe permettersi, ma non può”.
George Steiner, Linguaggio e Silenzio (Language and Silence, 1967)
Ogni qualvolta l’architettura ha saputo fare questione dei propri segni e fondamenti è riuscita a stabilire un rapporto con l’«altro». È un rapporto che nel corso delle vicende è di volta in volta mutato con il transitare dell’uomo attraverso soglie che ne hanno vieppiù modificato le pratiche e i saperi, e che a loro volta hanno modificato l’uomo che ad esse da sempre è soggetto.
Dalle prime rappresentazioni parietali dell’uomo paleolitico all’alfabeto, passando attraverso i pittogrammi, i geroglifici, i sistemi di scrittura sillabici, l’uomo si è confrontato con esperienze che hanno influito nel modo di figurarsi il mondo e il suo rapporto con esso. Propriamente, «l’uomo» si riconosce come tale solo a partire da una soglia specifica.
Ripercorrendo le vicende del passato nel modo in cui ci è dato ripercorrerle ci esponiamo a quell’esercizio genealogico che ci consente, in prima istanza, di guardarci criticamente nel tentativo di comprendere quali soggetti siamo vieppiù diventati e il modo in cui lo siamo diventati attraverso l’intreccio di innumerevoli pratiche in sinergia e perenne trasformazione. Nel modo di pensare il nostro rapporto con l’«altro» tutto ciò ha evidentemente un ruolo essenziale. Come pure nel comprendere il modo in cui è mutato l’approccio dell’uomo nei confronti dello «spazio», del «tempo», della «luce», della «materia», che non sono nient’altro che metafore che da un certo momento in avanti l’uomo impiega ma che non esistono come tali, come cose «assolute» (ab-solute, cioè sciolte dalle pratiche che le mettono in opera), né esistono come cose esistenti «in sé» al modo in cui le parole le dicono e le designano. Che la maggior parte degli architetti, oggi, non sia in grado di esporsi al rapporto con l’«altro», di pensare criticamente i fondamenti della propria pratica, va di pari passo con il venir meno del senso dell’architettura, che si è via via disseccato nel significato di una «vita calcinata», come diceva Antonin Artaud (figura che nell’aiutarci a riscoprire il senso dell’architettura come mezzo per «rifare» la vita avrà un ruolo fondamentale).
Questo non significa né assumere atteggiamenti nostalgici né rifugiarsi nella tradizione di saperi esotici od orientali, mettendo in atto quelle categorie aristoteliche che intendiamo superare e che fanno dire che, invece, quelle tradizioni sono più vere rispetto a quella che ci ha costituiti come soggetti occidentali. Ma dall’altro lato ciò non deve indurre ad elogi indiscriminati e superstiziosi di quel sapere scientifico e tecnologico che la modernità ha imposto e andrà vieppiù imponendo alle altre culture e tradizioni (sempre più sul punto di scomparire dalla faccia della terra). Il punto allora è cercare di esporci ad un abito etico (che non ha nulla a che fare con la teorizzazione di scale di valori) verso il quale alcuni filosofi ci stanno da tempo richiamando nel tentativo quanto mai urgente e necessario di «tornare a casa» e ricostruire l’arte «rituale» della nostra formazione. E se l’architettura ha una parte così importante nei modi di vivere dell’uomo, è evidente che gli architetti non possono per nessun motivo rinunciare a rimettere in discussione il modo di esercitare la loro pratica secondo prassi consolidate del «si fa» perché «si deve». In simili atteggiamenti si cela infatti quell’«oggettivazione» della vita che la declina in quella «banalità del male» di cui ha parlato Hannah Arendt e in cui, invero, si annida la possibilità e il pericolo congenito nella meccanica ripetizione capace di produrre una globale retrocessione nella barbarie.
Noi «veniamo dopo», come ormai sappiamo e non possiamo far finta di non sapere. Ciò non significa che nelle vicende umane non siano rintracciabili vie alternative e slanci creativi capaci di aprirsi ad un senso solidale dell’umano che il nostro tempo in molti modi suggerisce e sollecita. Alcuni di questi slanci sono stati in questo lavoro registrati e percorsi. Non sono i soli a cui avremmo potuto riferirci, ma in qualche modo sono quelli che riteniamo più significativi ed efficaci ai fini proposti. Giunti al termine del percorso si capirà che neppure un approccio all’«ecologia» può prescindere dall’aver pensato e conseguito un autentico rapporto con l’«altro». Con ciò si intende un autentico rapporto con gli altri uomini e il mondo, non più visti e pensati come mere contingenze ma come «occasioni» verso le quali disporci, pronti ad offrire adeguati abiti di risposta.
Si tratta di sapere cosa vogliamo, diceva Artaud, si tratta di sapere se desideriamo perseverare in atteggiamenti irresponsabili e da snob o se vogliamo tentare di attingere ad un’autentica coscienza delle forze che potrebbero essere messe in movimento. Non è una cosa di poco conto, ma è un esercizio dal quale, già nello stesso istante in cui ne acquisiamo consapevolezza, non ci è dato prescindere.
Vogliamo richiamare una vicenda recente, nei confronti della quale abbiamo espresso una posizione critica (attraverso la quale dissentiamo da molte altre letture, fra cui parzialmente da quella che ne ha proposto Giorgio Agamben ). Il fatto riguarda la costruzione del memoriale degli Ebrei d’Europa progettato da Peter Eisenman e inaugurato a Berlino a distanza di otto anni dal concorso che venne indetto per l’occasione. La proposta dell’architetto vinse su quella del teologo protestante Richard Schroeder che prevedeva una colonna recante l’iscrizione in più lingue «Non uccidere». La vasta area è delimitata da quattro strade – Ebertstrasse, Behrenstrasse, Cora Berliner Strasse e la Hannah Arendt Strasse – e accessibile da ogni lato. Si tratta di circa 2500 stele di cemento, distanziate di soli 95 centimetri, con altezze e inclinazioni variabili, tali da annullare qualsiasi nozione di assialità assoluta, illusioni d’ordine e sicurezza. Una selva senza fine, senza meta, senza vie d’entrata né d’uscita.
“Eisenman sembra essersi posto questo problema: trasformare il monumento in un’esperienza individuale. (…) Ricordo dei morti, ma anche meditazione sul nostro spazio vitale. Per questa ragione la successiva costruzione dell’Ort der information (Luogo dell’informazione) sotterraneo, posto sul lato estremo della foresta di stele, in cui trovano posto l’archivio dei nomi, fotografie, bacheche e altri servizi, risulta svilente. Una concessione posticcia e tardiva alla necessità di informare e commentare che evidentemente ossessiona i committenti tedeschi. Tutto il contrario di quanto Eisenman si proponeva”. Così Marco Belpoliti scriveva sul numero 881 di Domus, concludendo: “Nell’Ort der Information la memoria collettiva prevarica su quella personale o almeno ne smorza la difficile dialettica. La didattica prima di tutto? Una debolezza imperdonabile? Oppure la necessità di produrre ancora una volta una «memoria politica», politicamente corretta?”.
Ne L’eredità di Auschwitz, Georges Bensoussan afferma che ciò che la Shoah ha rappresentato sfugge alla normale comprensione, e la politica della memoria deve mutarsi in politica della storia o, forse, in un imperativo per la comunità, “giacché l’invocazione alla «memoria», questa nuova religione civile, non costituisce una barriera. Il ricordo non difende né protegge da nulla: non si educa contro Auschwitz”. Le frasi di circostanza, l’informazione capace di provocare nel migliore dei casi una sincera compassione, non rappresentano che l’ennesimo tradimento fatto alle vittime. Se, come vuole Bensoussan, non si può educare contro Auschwitz – proprio perché è l’evento che determina un prima e un dopo e, come tale, mette in discussione il nostro stesso statuto di esseri umani – dobbiamo educare dopo Auschwitz. La conoscenza della Shoah non può non cambiare colui che la fa propria, coinvolgendolo in ogni fibra dell’esistenza.
Paul Celan, Jean Améry, Primo Levi, hanno preferito morire piuttosto che continuare a vivere in un mondo sempre più sordo alle loro parole. L’insegnamento della Shoah deve andare al di là del solo antisemitismo, anche se questo resta lo sfondo della catastrofe. Esso deve chiarire ciò che Primo Levi chiamava la «zona grigia», l’onesta mediocrità umana, quell’universo essenzialmente conformista di assassini, un mondo di impiegati che «fanno carriera». Non si può dissociare la disumanità dall’umanità. La memoria deve porre interrogativi lancinanti e irrinunciabili alle strutture del nostro presente, deve essere memoria viva, non compiaciuta commemorazione che si limita a «fare riflettere sull’orrore». Il riesame non può avere carattere moraleggiante.
Informare per conformare le coscienze è quanto di più folle si possa pensare, e porta ad esiti diametralmente opposti a quelli che ci si vorrebbe figurare. Nel capitolo Insegnare cosa?, Bensoussan conclude: “Un tempo la ragione chiariva l’avvenimento; oggi è l’avvenimento a illuminare la ragione, a mettere in discussione le nostre pratiche sociali, i nostri codici e linguaggi, l’uso banale delle parole che determinano la nostra identità. La normalità delle nostre società getta un’altra luce sul nazismo, e la prospettiva storica ci fa capire che il più delle volte ragioniamo stabilendo dei confini illusori tra ciò che è umano e ciò che è disumano”.
Se l’Ort der information rappresenta “tutto il contrario di quanto Eisenman si proponeva” uccidendo la memoria viva per ricadere nella «normalità» conformistica attraverso la quale Auschwitz uccide ancora, non si capisce perché l’architetto abbia accettato di proseguire nell’incarico.
Non si tratta né di atteggiamenti moralistici o moraleggianti, né di posizioni «intransigenti oltre il dovuto». Si tratta semplicemente di offrire l’esempio di una corrispondenza tra abito mentale e scelte di vita. È ciò che si riscontra in persone disposte a rinunciare a tutto pur di inseguire i propri ideali. È ciò che è capitato in quella piccola Repubblica del Cantone Ticino qualche anno addietro, precisamente il 1 ottobre 2001. Ci riferiamo all’esperienza di Stefano Malpangotti, il quale, oltre ad offrire una rara profondità di pensiero, incarna l’esempio di una straordinaria corrispondenza tra abito mentale e scelte di vita. Egli sa che ciò che è davvero urgente è una profonda rivoluzione del nostro modo di essere e di praticare cultura, condizione raggiungibile unicamente attraverso una presa di coscienza personale (almeno una volta nella vita, diceva Husserl, ma prima di lui Cartesio, bisogna tornare a se stessi) e attraverso il duro esercizio di ognuno. Vale in proposito citare un esempio che, in fondo, dice tutto ciò che c’è da dire.
Nel marzo 2001, ancora deputato, egli inoltrò – dopo il rifiuto da parte del Consiglio Nazionale del postulato del deputato Joseph Zisyadis – una lettera al capo del Dipartimento federale degli affari esteri, Joseph Deiss, nella quale chiedeva al Consiglio Federale l’impegno a riconoscere il genocidio armeno del 1915. Il 22 dello stesso mese, Malpangotti inoltrò al legislativo ticinese una proposta di risoluzione, inviandola in copia all’allora presidente della Confederazione Moritz Leuenberger e allo stesso Deiss, affinché con i propri colleghi e a nome del Consiglio Federale riconoscessero ufficialmente l’esistenza del genocidio. Il primo ottobre, dopo sei mesi, Malpangotti dimissionò dal Gran Consiglio del Cantone Ticino poiché la sua risoluzione non poté essere discussa in quanto mai inserita nell’ordine del giorno di nessuna riunione dell’organo legislativo. La lettera, indirizzata al Presidente del Gran Consiglio Ignazio Bonoli, riportava fra molto altro i passi seguenti:
“Sono passati sei mesi, signor presidente, e non ho ancora inteso una voce dichiarare o balbettare una decisione. Nemmeno esiste un segno in una sperduta lista di sospesi in Gran Consiglio. Non ci sono giustificazioni a tanta indifferenza, per quanto involontaria. Non ci sono formalismi di alcun genere da opporre. Non tanto per il fatto che venga o meno accettata la risoluzione, ma perché nemmeno è stata considerata. Non è stato cioè considerato questo: lo sterminio di almeno un milione e mezzo di essere umani.(…) È questa indifferenza che tratta l’uomo come un oggetto, come una cosa, a rendere possibile il mostruoso. E allora chiedo: come si può essere indifferenti davanti a questa disumana indifferenza? Come si può? (…) riconoscere il genocidio degli Armeni, e con esso l’esistenza di crimini contro l’umanità, vuol dire affermare la dignità di una vita per la quale si vuole che si viva insieme o non si viva affatto. Ma questo esige, signor presidente, una politica intesa come umanità e cultura e non come potere e calcolo. (…) Tutto il resto è ipocrisia. A meno di rinunciare a rimanere all’interno della comunità degli uomini. A meno di lasciar morire ogni germoglio d’amore che ci tiene legati a tutto ciò che è vivente. E siccome questa non è mai stata la mia scelta, signor presidente, per rispetto ai valori universali dei diritti dell’uomo e della dignità umana, con questa lettera inoltro le mie dimissioni immediate dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino”.
I contenuti della lettera non vennero riportati da nessun organo di stampa cantonale. Non se ne volle comprendere né il senso né il movente. Altrove fu diverso, ma all’interno dei confini ticinesi si preferì il silenzio, la complicità, la pigrizia intellettuale, la rassegnazione colpevoli, l’opportunismo cinico e calcolatore. Nel peggiore dei casi il dileggio, l’umorismo a buon mercato, la calunnia gratuita, l’abbandono ad esternazioni e reazioni che non esiteremmo a definire naziste. Dopo Stefano Franscini, il Ticino perse in questo modo un’altra occasione. Tutto questo per chi vorrà capire.
Le premesse per poter comprendere il senso di questo lavoro stanno tutte qui. Qui è in gioco la vita stessa. La vita intesa quale capacità di ordinare l’esperienza intesa come opera di scrittura, così come in queste pagine si tenterà di dire. Un’esperienza che la scrittura trasmette non raccontando storie -«oh, quante storie!», direbbe il buon filosofo – o la storia, che come tale non esiste ed è uno dei frutti di quelle «superstizioni materialistiche infinite» di cui parlava Spinoza, o di quelle immaginazioni «umane, troppo umane», di cui diceva Nietzsche, da buon spinoziano qual era.
La scrittura trasmette propriamente esperienze. Riferendoci all’esperienza non alludiamo evidentemente alle letture che ne hanno dato il Settecento e in particolare l’Ottocento, che hanno tradotto la nozione di esperienza con quella di empirismo, rileggendola e reinterpretandola secondo categorie estranee alla cultura dei tre secoli precedenti, e provocando la successiva reazione, da Kant a Hegel. Non è un caso se nelle pagine che seguono, fra le figure di riferimento si incontreranno Giordano Bruno e Leonardo da Vinci. Francesco De Sanctis aveva già messo in luce la grandezza di Bruno, come pure quella di Macchiavelli, depurandone la lettura da tutte quelle incrostazioni e luoghi comuni che ancora la nostra cultura si porta dietro attingendo ad ermeneutiche stucchevoli e modaiole, spesso di seconda o terza mano.
La scrittura trasmette quindi le esperienze dell’uomo, raccontando le sue favole. Ma in questo modo è la stessa nozione di testo che muta, allargandosi fino a coprire tutto il campo dell’esperienza. Carlo Sini, anche con illuminanti scritti sull’opera di Peirce, lo ha mostrato in modo mirabile. Havelock in qualche modo lo aveva intuito affermando che “noi recitiamo il ruolo di un eterno Odisseo che alza le vele per un paese lontano, fin quando per avventura non farà ritorno in patria riconoscibile e rinnovato”.

Diego Caramma
2002
Architettura Oggi.
Nuove Tendenze
Testo & Immagine
Una delle prime e più penetranti monografie dedicate all’architetto giapponese, i cui contenuti sono stati successivamente approfonditi in uno dei capitoli di Tracce d’architettura, Seneca Edizioni, 2008.


Diego Caramma
2001
Spazio-architettura
Nata nel 1999 sotto forma di lettera elettronica, questa iniziativa è maturata nel 2001 in forma di rivista cartacea monografica e tematica. Oltre alle pagine dedicate all’architettura, in ogni numero trovavano spazio rubriche di arte e fotografia, design, filosofia. Gli editoriali e le cronache brevi definivano la linea editoriale della rivista che veniva stampata con mezzi propri dapprima mensilmente e poi, negli ultimi due anni, a scadenza bimestrale, prima di tornare sul web sotto forma di portale elettronico.
A differenza della maggior parte delle riviste, Spazio-architettura non era nata per questioni di potere o prestigio: rifiutava sostegni economici e qualunque tipo di finanziamento per poter essere totalmente libera, perché era nata dall’esigenza di aprire le porte a ricerche che non avrebbero mai trovato spazio altrove.
È stato recentemente riconosciuto da Anna Baldini: «Un accenno, però, è doveroso alla prima rivista, l’antesignana, che si è occupata di ricerca di nuovi linguaggi, di nuovi fenomeni culturali e di nuovi talenti, Spazio-architettura (…) uscita alla fine degli anni ‘90 prima su carta e poi sul web. Tutte le tematiche che oggi vengono proposte come novità sono state già indagate da questa rivista e alcuni degli architetti che sono in mostra al Maxxi, già erano stati scoperti (…) e pubblicati su Spazio-architettura».
Prima ancora, ne ha scritto Giovanni Bartolozzi: «la rivista Spazio-architettura ha rappresentato, negli ultimi anni, l’unica vera voce, limpida e problematica per l’avanzamento dell’architettura contemporanea».
Oltre che qualificarsi per ciò che pubblicava, si qualificava anche per ciò che non pubblicava: fra le altre cose, non ha mai pubblicato «star» dell’architettura.
Non era nata come una sfida da vincere, ma come un dovere da compiere. Sarebbe durata per il tempo necessario, non essendo stata creata da chi aveva la necessità di identificarsi con un ruolo, qualunque esso potesse apparire… e al momento opportuno, molto semplicemente, sarebbe scomparsa, nello stesso modo in cui era apparsa.